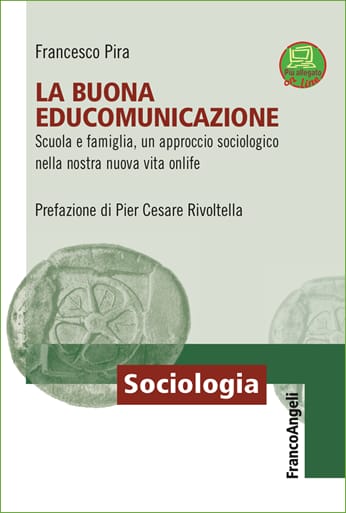This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Mi amo troppo per stare con chiunque
a cura di: Prof. Mariano Indelicato, Presidente Pronto Soccorso Psicologico Italia
L’ennesimo efferato femminicidio anche per le modalità con cui è avvenuto apre in apparenza molti interrogativi poiché metaforicamente rappresenta il disagio e il grande stato di crisi in cui vivono gli adolescenti e, soprattutto, le dinamiche di trasmissione generazionale. Sul corpo esamine di Sara credo che i genitori, le agenzie educative e socializzative dovranno fare attente valutazioni di fronte ad adolescenti sempre più violenti e che uccidono per un “no”. In questo caso le categorie con cui sono stati analizzati i femminicidi in passato non reggono e il volerle testardamente riproporre appare come un alibi per evitare di essere coinvolti in analisi che possono coinvolgere tutti.
E’ stato invocato il patriarcato che in casi come questo spesso, nel passato, si risolveva con il rapimento della donna per metterla di fronte al fatto compiuto in un contesto in cui la verginità femminile rappresentava un tabù sociale da non poter infrangere. Basti pensare per un attimo al caso di Franca Viola. Nel contesto patriarcale però l’uccisione delle donne era considerato un disonore per chi si macchiava di un tale delitto. In quel tipo di contesto le donne e i bambini godevano di protezione mentre altre erano le violenze che erano consentite ai maschi rispetto alle donne. Per tale motivo in questo caso, come in quello di Giulia Cecchettin, appellarsi al patriarcato appare una spiegazione semplice e fragile.
Non ci si può appellare neanche alla dipendenza affettiva poiché questa presuppone una relazione tra la vittima e l’assassino che non è neppure iniziata poiché Sara aveva sempre respinto il corteggiamento assillante di Stefano Argentino. La dipendenza affettiva, infatti, nasce e si sviluppa all’interno di una relazione “malata” e di un rapporto contraddistinto dalle difficoltà ad esprimere e provare sentimenti di amore. Invece Sara viene uccisa, in apparenza, solo e semplicemente per aver difeso un suo scopo e obiettivo di vita “mi amo troppo per stare con chiunque”, per un “no” in un contesto sociale, come quello giovanile attuale, che non riesce a sopportare la frustrazione legata al diniego. In un contesto adolescenziale in cui l’Altro diventa un oggetto che si deve piegare con tutti i mezzi, compresa la violenza e la sopraffazione, ai propri desideri.
I dati di ricerca in questa direzione sono allarmanti. Una ricerca condotta su 5 mila studenti sardi dall’Osservatorio Cybercrime Sardegna emerge che “Il 5.8% degli studenti ha utilizzato un’arma, il 42 per cento ha partecipato a zuffe e risse. Mentre il 7.5% ha riferito di aver fatto seriamente male a qualcuno (tanto da dover ricorrere ad un medico)”. Luca Pisano, direttore dell’osservatorio, nel commentare questi dati afferma che “sono sempre più numerosi i ragazzini delle scuole superiori della Sardegna che vanno in giro con armi bianche spesso costruite guardando i reel su Tik Tok: Sono armati di coltello, tirapugni, sfollagente. Ma usano anche i martelletti frangivetro che rubano dagli autobus su cui viaggiano per andare a scuola. Su internet apprendono come costruire i coltelletti, usando un pennarello e una lametta che si portano dietro nello zaino”.
Un altro studio, ESPAD®Italia, condotto dal CNR su 20 mila studenti provenienti da 250 scuole mette in evidenza che sono aumentati i i comportamenti più estremi come il colpire un insegnante e utilizzare un’arma per ottenere qualcosa. Sabrina Molinaro, dirigente del progetto, fa rilevare che “Siamo di fronte a una generazione profondamente immersa nel digitale, che rischia di sottovalutare la gravità della violenza, soprattutto quando mediata da uno schermo”. I dati della ricerca mostrano che “riprendere e condividere episodi violenti sia diventato quasi normale per molti adolescenti, alimentando un pericoloso distacco emotivo dalle conseguenze reali delle proprie azioni. In un contesto in cui la violenza può trasformarsi in contenuto virale, si smarriscono empatia, responsabilità e senso del limite”. E continua scrivendo che “abuso di alcol e droga fanno il resto: Ed è proprio in questo scenario che stupisce e preoccupa la facilità con cui alcuni giovani arrivano a impugnare un’arma, colpire un insegnante o ferire gravemente un coetaneo. L’incremento di questi comportamenti estremi, evidenziato dallo studio, suggerisce che l’assuefazione alla violenza, unita a fragilità relazionali e assenza di riferimenti educativi forti, stia generando una pericolosa normalizzazione dell’aggressività, trasformandola in strumento di espressione o, peggio, di appartenenza ”.
E’ all’interno di questo contesto e con questi parametri che dobbiamo spiegarci quanto avvenuto l’altra sera a Messina. Le vecchie categorie con cui abbiamo letto i femminicidi non bastano e possono anche diventare fuorvianti e, soprattutto, non permettono una presa di coscienza collettiva che possa permettere di costruire un tessuto sociale e educativo alternativo, pensato per riparare i danni che in questi anni sono stati prodotti attraverso la promozione del benessere di tipo edonico in cui la ricerca della felicità è diventato il totem con cui doversi confrontare, senza tenere conto delle esigenze etiche necessarie alla costruzione della convivenza civile.
La ricerca della felicità, il raggiungimento della terra promessa spesso è stata presentata come la soddisfazione di tutti i desideri. Le scienze pedagogiche, psicologiche e sociali in genere, sono state impegnate sul pathos, sulle esigenze di carattere pulsionale, senza tenere conto delle esigenze etiche. Eppure già Freud, in Disagio delle Civiltà, aveva ammonito che la convivenza sociale è possibile solo se la pulsione viene differita alla meta. Lacan, riprendendo questo concetto, afferma che il godimento del desiderio è possibile solo attraverso la Legge. Scabini e Cigoli, nel definire i legami inter e trans generazionali, indicano che quest’ultimi devono essere inseriti all’interno di due poli: il pathos e l’ethos. Pensare che il benessere psicologico sia il raggiungimento della felicità e, quindi, della ricerca del piacere comporta i disagi che le nuove generazioni stanno vivendo. Sono stati abbandonati in questi anni le esigenze di carattere etico, viviamo in una sorta di anarchia in cui la meta da raggiungere è diventato il piacere.
Siamo tutti diventati figli di Andrea Sperelli, il celebre personaggio del Piacere di D’annunzio, il quale costruisce la sua vita come un’opera d’arte e rifiuta le regole basilari del vivere morale e sociale.
Abbiamo demolito tutto ciò che proveniva dal passato etichettandolo come vecchio e stantio ed insieme alle storture abbiamo tralasciato anche ciò che di buono proveniva dalle generazioni precedenti. Per dirla con un detto popolare abbiamo buttato il bambino insieme all’acqua sporca. Ed ancora più grave è che a fronte di quest’opera di demolizione non siamo riusciti a costruire un modello alternativo da dare alle nuove generazioni. Ho tante volte paragonato la fase che stiamo vivendo a quella del ferro di esodiana memoria in cui “ Figli diversi dai padri e padri diversi dai figli………maltratteranno i parenti appena attempati li copriranno di male parole e d’insulti, gli infami senza rispetto divino. Costoro neppure daranno il necessario per dare da vivere ai vecchi che li hanno allevati…sarà abbandonata la terra con le sue strade spaziose, agli uomini il pianto e il dolore. Contro il disastro per gli uomini non ci sarà riparo”. In sostanza stiamo assistendo alla rottura del patto generazionale con tutti i rischi insiti in questa operazione. Già Lacan negli anni ‘70 ha teorizzato l’evaporizzazione della figura paterna come luogo della “Legge”, delle condotte morali. Questo comporta, da un lato, la possibilità che i desideri possono essere soddisfati al di là e indipendentemente delle regole di convivenza civile e, dall’altro, il mancato riconoscimento dell’altro come persona portatore di una sua identità che, al contrario, è diventato solo un oggetto, come un gelato o un cibo prelibato o meno, da utilizzare ai propri fini. L’odio generazionale, come informa Cigoli, è di particolare interesse clinico, per cui è necessario “coglierne le forme e, al contempo, le strategie per affrontarlo .. l’odio si presenta con il volto della menzogna, dell’iniquità, dell’invidia e della crudele indifferenza”.
Emblematico a tal proposito appare il comportamento dei genitori e, in particolar modo, della madre dell’assassino di Sara. Dalle interviste e dai resoconti giornalistici emerge che solo quella sera e notte si rende conto dei disagi del figlio. Infatti, riporta che il figlio in un estremo tentativo di chiedere aiuto le dice che vuole morire perché incapace di amare e di farsi amare prima di confessargli l’orrendo delitto di cui si era macchiato. Credo che sia legittimo chiedersi: dov’è stata questa donna in tutti questi anni che non si è mai accorta di questa difficoltà del figlio? Semplicemente non c’ è stata, non è stata in grado di sintonizzarsi sulle esigenze, sul malessere che covava dentro il figlio. Spesso i genitori sono distratti, presi dalle loro inquietudini quotidiane per cui la cura responsabile dei figli che dovrebbe essere il presupposto primo dell’essere genitori passa in secondo piano o viene abbandonata del tutto. Tante altre volte, sono presi dai loro problemi di coppia e/o delle nuove famiglie che si sono costruite e i figli rimangono sullo sfondo, senza nessuno che si occupi di loro. Rimangono tutti come Berthe la figlia di Madame Bovary che occupata nelle sue vicende amorose non ha tempo di occuparsi della figlia.
La mia ipotesi è che il figlio nell’uccidere Sara abbia, metaforicamente, ucciso anche quella madre che non gli ha imparato ad amare e, soprattutto, il non essere mai stato oggetto d’amore. E’ compito dei genitori, infatti, imparare ad amare e a far sentire i figli oggetto d’amore. Da quello che emerge, invece, la relazione genitori – figlio è estremamente invischiata non permettendo, come insegna Cancrini, un effettivo svincolo. Con Cigoli potremmo affermare che il figlio non viene messo nella condizione di rielaborare la sua storia generazionale in modo da poter rilanciare il patto generativo. Non è sicuramente frutto della casualità che dopo aver ucciso Sara chiama i genitori invece di darsi alla fuga da solo o farsi aiutare da amici ammesso che ne avesse. E li cerca dicendogli che vuole farla finita, chiedendo in maniera paradossale che per una volta potessero totalmente occuparsi di lui e potessero lenire le sue sofferenze.
Inoltre, nel momento in cui confessa quanto commesso, i genitori invece di metterlo di fronte alle sue responsabilità invitandolo a costituirsi lo nascondono nel b&b di famiglia progettando, almeno come ipotizzato dagli inquirenti, la fuga. Non è il primo caso di comportamento anomalo dei genitori di fronte a delitti dei figli. Pochi mesi fa un altro padre, dopo la confessione del figlio di aver ucciso una persona nel tentativo di rubargli una sciarpa, lo protegge e lo nasconde. Sarebbe questo il modo per trasmettere le regole etiche ai figli?
Eppure, anche se non in maniera cosi drammatica, ogni giorno assistiamo a comportamenti simili soprattutto nel rapporto tra scuola e famiglia, tra insegnanti e genitori. Quest’ultimi di fronte a provvedimenti o a cattivi voti degli insegnanti sono sempre pronti a giustificare i figli se non a punire severamente gli stessi educatori. La cronaca riporta molte aggressioni di genitori nei confronti degli insegnanti. Ancora una volta quelle che vengono meno sono le regole di carattere etico utili al fine di una sana convivenza civile. Viene meno a dire di Lacan la “Legge” che assume una duplice di funzione sul desiderio. Infatti, quest’ultimo nasce dal vuoto, dall’assenza, dalla mancanza e per poter essere provato ha bisogno di tanti “No”.
In letteratura vengono descritti due tipi di madri la good enough mother (la madre sufficientemente buona) e la madre castrante. Le prima è la madre che riesce a sintonizzarsi sulle esigenze del figlio e nel farlo deve essere consapevole che deve dividere il suo cuore a metà ovvero deve lottare contro la tendenza ad esaudire tutte le esigenze, i desideri del figlio con la necessità di dover insegnargli che non tutti i desideri possono essere esauditi. I figli per crescere hanno bisogno di provare il sentimento della frustrazione solo in questo modo possono diventare resilienti di fronte ai tanti no che riceveranno nella vita. D’altronde già Freud nel descrivere lo strutturarsi dell’apparato psichico aveva indicato nel “no” la nascita del principio di realtà contrapposto a quello del piacere che, invece, tende alla soddisfazione immediata delle pulsioni. Nell’ambito della relazione tra genitori e figli sta ai primi far tenere conto di una realtà esterna che non deve per forza piegarsi alle mie pulsioni. In sostanza nell’ambito di una relazione si deve tenere conto della volontà dell’Altro che può anche dirci di no poiché non è una diramazione di noi stessi o, semplicemente, l’oggetto che deve esaudire i nostri desideri.
Dall’altro lato c’è la madre castrante che è sempre pronta non solo ad esaudire i desideri del figlio, ma addirittura ad anticiparli. E’ la madre incapace di dire di no, colei che tende ad esaudire immediatamente tutti i desideri dei figli.
Inoltre, come da tempo ha ben compreso la sociologia , soprattutto attraverso le teorie di Baumann, il passaggio dalla società della comunicazione a quella dei social e delle iperconnessioni ha comportato la modificazione del principio di velocità in un nuovo imperativo: la necessità dell’immediatezza.
In una società il cui tratto distintivo è diventata l’estetica, la ricerca della bellezza a tutti i costi, Baumann ha descritto la relazione tra l’Io e l’Altro come una fornitura di beni e servizi del secondo nei confronti del primo. L’Io non ricerca l’Altro nella sua essenza ed autenticità ma semplicemente per soddisfare le sue esigenze. Come messo in luce da Muscelli, non si è alla ricerca di una conoscenza approfondita dell’Altro, ma l’interesse è semplicemente estetico in cui l’altro è “da assaggiare e sentire” come se fosse un gelato e/o un dolce. Nella relazione di immediatezza l’altro non è il partner con cui dialogare, a cui rendere conto, di cui sentirsi responsabile, verso cui vergognarsi.
Insomma non solo le madri sono diventati castranti ma anche l’intero sistema sociale e culturale. Se dovessimo utilizzare le categorie nosologiche dei sintomi psichici dovremmo concludere che viviamo in una sorta di psicosi collettiva in cui l’unico centro di interesse sono le mie esigenze pulsionali senza tenere conto dell’esistenza dell’Altro.
La morte di Sara è frutto di tutto ciò e nessuno di noi è esente da colpe. Anzi, al contrario, di fronte al suo corpo ci dovremmo dichiarare tutti colpevoli. Il continuare a trovar scorciatoie, o nell’accusare questo o quell’aspetto senza tenere conto che dobbiamo tutti impegnarci a fare il necessario cambio culturale che possa pemettere alle nuove generazioni di vivere un benessere non effimero come quello edonico ma, semmai, lavorare verso quello che tanti anni fa Aristotele definì eudaimonico. In quest’uiltimo bisogna imparare che lo scopo della vita non è quello della ricerca della felicità individuale bensi di quella collettiva. Solo cosi potremmo non solo far rivivere Sara ma, soprattutto, evitare che fenomeni di questo tipo si possano ripetere.

Prof. Mariano Indelicato, Presidente Pronto Soccorso Psicologico Italia